Mentre imbevevo di grandi lacrime l’ultima pagina de L’eleganza del riccio, mi sono ricreduto sull’impressione che le cose, sul finale, stessero procedendo un po’ troppo in fretta. Più che un’osservazione critica, la mia si è rivelata una forma di dispiacere simile a quello che si prova durante il viaggio di ritorno verso casa da una vacanza bellissima. Fin dal primo momento sei consapevole della brevità dell’esperienza, che nasce proprio come momento di divagazione per spezzare il quotidiano a te destinato. Sai che finirà, e non può sorprenderti l’arrivo repentino del termine ultimo, l’istante in cui metti piede in macchina, chiudi lo sportello e saluti sorridendo dal finestrino coloro i quali non conoscevi e che vorresti frequentare indefinitamente per tutto quello che hanno saputo depositare nel tuo terreno fertile. Così mi sono sentito quando ho chiuso L’eleganza del riccio, per non poter più rivedere la portinaia Renée Michel e la piccola Paloma; dover lasciare il maestoso palazzo al numero 7 di rue Grenelle – Parigi, con le famiglie facoltose che lo abitano e le comprensibili superficialità di cui Renée non ha nessuna voglia di farsi carico. Per fortuna ero solo a piangere, accovacciato dove ci si accovaccia in bagno, nel mio sacro primo momento di lettura mattutina. A vedere un quasi trentunenne piangere, come un adolescente ai titoli di coda dell’ultima puntata di Dowson’s Creek, non è che ci si senta proprio in mano a una salda gioventù. Non mi capita spesso di commuovermi per un libro, più per un documentario, per dire. Ricordo benissimo l’elefantessa partoriente su Rete4. Non ci riusciva, alla ricerca della giusta posizione fra lamenti di dolore, e un’elefantessa che si lamenta non emette esattamente il cinguettio di un fringuello. Finché ce l’ha fatta. L’applaudivo, steso sul letto a pangia in giù e, con la bocca impastata di bava emozionale, esclamavo: Che bello! La commozione non è indispensabile per decidere una buona storia, come non è intento di tutti i bravi autori provocare la discesa di una lacrimuccia dagli occhi del lettore. Certo che, quando capita così come è capitato a me, non può che essere figlia di un coinvolgimento fisico e mentale, e questa sì che è un’ottima variabile decisionale. Per scegliere se acquistare oppure no un libro, che ha già venduto tanto in mezzo mondo, cerco sempre di rispondere a un interrogativo che mi autopongo, spesso pure ad alta voce: Come mai, secondo te, sta piacendo a così tanta gente? Che tipo di lettori sono costoro che lo amano? Sono o potrebbero essere inclini a te (me), oppure proprio no? Faccio un esempio partendo da una premessa rischiosa: Federico Moccia è uno che vende molto. Vi prego, andate alla ricerca dell’aspetto costruttivo guardando oltre, leggendo fra le righe; non limitatevi all’insulto intrinseco nell’esempio stesso, che vi rassicuro c’è, però c’è anche dell’altro insomma. La domanda che mi autopongo in libreria è: Cosa abbiamo in comune io e i lettori dei libri di Moccia? Si potrebbe rispondere frettolosamente: Niente! marcando il punto esclamativo fino a strappare il foglio, ma vi assicuro che non è così semplice. Ogni risposta va motivata attraverso documenti inconfutabili o almeno una serie di indizi utili, altrimenti rimane soltanto un’opinione che non può assicurarmi che, sempre per esempio, io non sia il lettore ideale dei libri di Moccia. (Aaahhh dolore!) Così mi metto alla ricerca delle mie risposte che trovo nei suoi lettori e lettrici entusiasti, perché è con quelli che devo confrontarmi per capire se potrò essere uno di loro, e quindi se vale la pena, per me, acquistare un libro di Moccia. Li studio sui social network, leggo i commenti lasciati sotto alle schede nelle librerie virtuali e, signori, no. Io non sono così. Non potrei mai essere amico di una che, per scrivere perché, utilizza 2 caratteri soltanto, contando pure l’apostrofo dopo la X, oppure di uno che aggredisce i detrattori esordendo con: Voi non capite gnente dei giovani che racconta Federico. Ma gnente scritto proprio gnente. Questa indagine non vuole stabilire se Moccia è la voce più talentuosa della narrativa moderna o un disadattato arricchito col cappellino, ma dà a me la certezza che le sue opere non toccherebbero le mie corde, non nutrirebbero la mia fame (ma riscalderebbero il salotto di Villa Madre forse più del pellet ecologico che alimenta la stufa).
A questo punto dico che vorrei diventare amico di quanti più lettori possibili de L’eleganza del riccio. Coloro che hanno invidiato l’abilità di Renée nel celare la sua vera natura: la cultura, gli interessi e la grandezza interiore che per nulla si confà all’immagine di una portinaia, l’ultima della scala sociale per chi continua a darle compiti, ma non fa un solo tentativo per riuscire a vederla davvero. Coloro che hanno amato Paloma, sorprendendosi di imparare tanto da una ragazzina con istinti suicidi e incendiari, che non riesce proprio ad apprezzare la vita perché in gabbia, lei che si riscopre così simile a Renée. Coloro che hanno capito subito che il nome del gatto Lev era ispirato al grande Tolstoj, e si sono emozionati perché Anna Karenina resterà sempre uno dei più bei romanzi che abbiano mai letto. Coloro che sanno cos’è una pioggia d’estate, che colpisce e non risparmia niente, e l’hanno saputa superare e pure apprezzare perché li ha cambiati e in meglio. Beh, sarebbe bello essere amici.
L’eleganza del Moccio
Pubblicato il
30 risposte a “L’eleganza del Moccio”
-
Be’ dai… ci ho provato a leggere ben due libri suoi… Non ce l’ho fatta ad andare oltre la metà di entrambi.
Detta alla mitica Sandra “che noia, che barba, che noia, che barba”
Un abbraccio!!!!ps.
Purtroppo in questo periodo (e solo in questo periodo, poi tornerà la normalità -spero-) passo sempre in ritardo, ma ci sono.-

Suoi di chi? Ah, del Moccio; per un attimo ho pensato di Muriel Barbery. Non importa quando, importa ritrovarsi.
-
-
Mi hai fatto proprio venire voglia di leggere “L’eleganza del riccio”…tra l’altro mia sorella ne ha una copia! Condivido l’apprezzamento di navemossa per Grossman!
-

Chiedi pure a tua sorella però, così poi, nel caso non ti piaccia, non te la prenderai solo con me. Buon week!
-
-
Eccomi qua, pure io amica tua. Di Moccia non ho letto niente, ma l’ultima pagina di questo libro l’ho letta in autobus mentre andavo a lavoro. Meno male che avevo gli occhiali da sole. Sono rimasta con la pagina aperta sull’ultima pagina, fino a quando non sono dovuta scendere.
-

Se mi fossi trovato in un luogo pubblico probabilmente mi avrebbero ricoverato.
-
-
Io non ho mai letto l’Eleganza del riccio, lo ammetto.
Veramente lo avevo sfogliato, con un misto di curiosità, poi ho visto il film che ho trovato noiosissimo ahimé…e quindi non l’ho più preso in considerazione!
Leggendo la tua affascinata recensione, forse dovrei riprovarci.
Condividere i libri è una delle cose più belle che si possa fare con un amico, perché condividi una parte di te!
Baci Matte!-

Mi hanno parlato della brutta riuscita del film che non ho visto e che, a questo punto, non vedrò mai, ma il libro per fortuna con la noia non c’entra niente.
-
-
E quindi io non farò citazioni di libri, non racconterò di cosa mi piace leggere e di cosa tengo ben lontano dal mio comodino.
Ti racconto però della difficoltà nello sfogliare l’ultima pagina di una storia bellissima, della corsa mentale senza respiro delle ultime righe perché cosciente che si tratti dell’unico modo a disposizione per staccarmene: uno strappo veloce e tanta malinconia.
A volte però non ho il fiato e resto con l’ultimo capitolo da leggere, e nella mia mente personaggi e luoghi restano eterni.
-

E’ una sensibilità rara, la tua, come rare immagino siano le storie che ti fermano dal voltare pagina. Grazie per le tue parole, che hanno fatto salire in me un brividino di emozione.
-
-
È ufficiale: siamo amici. Una prova ce l’hai qua.
-

Corro a leggerla, con la rassicurazione che mi dà la tua premessa ufficiale.
-
-
Scusate, ma Harumi Murakami qui solo io? Già che abbiamo la trasversaità giappa che incombe.
-

Harumi chi è, il fratello sfigato di Haruki?
A me piace tantissimo. Ho letto Norwegian Wood, un po’ (troppo?) straziante, ma bello bello. Mi sono piaciuti poi i racconti della raccolta L’elefante scomparso e sto aspettando di potermi gustare 1Q84 che sta sulla mia mensola e mi chiama. Ed è inutile che tergiversano; prima o poi il Nobel glielo devono dare per forza.
-
-
All’epoca non mi piacque molto, ma nell’ultimo anno i miei gusti sono totalmente cambiati.
Gli ultimi libri per cui mi sono commosso sono, ehm, non molto virili: “La dama e l’unicorno”, “Cime tempestose”.
-

Prova a rileggerlo! La dama e l’unicorno non è la biografia ufficiale di Cicciolina, vero?
-
No, ma in un certo senso ci sei vicino
-

Una lettura, quindi, assolutamente da recuperare! Buongiorno caro Speaker!
-
-
-
-
Ciao! Di Moccia ho letto solo “La passeggiata”, nella quale immagina di incontrare nuovamente il padre morto anni prima… mi è piaciuto, ma preferisco libri in cui il “tono dell’umore” sia un po’ più sostenuto..
-

Non conosco. Va be’ che non ne conosco nessuno, ma questo non l’ho mai sentito nominare. Evviva!
-
-
io non sono riuscita ad andare oltre la pagina 40. Mi avevano indisposto entrambe le protagoniste. E mi sono appellata al terzo emendamento del decalogo del lettore di Pennac! Il diritto di abbandonare un libro che non piace…
-

Mi sembra così strano. Com’è possibile che L’eleganza del riccio non piaccia? :O
-
non lo so. l’ho ricevuto in regalo appena uscito. ho sentito di amiche che lo hanno adorato, che ci hanno lasciato lacrime e sorrisi, e altre che come me non sono riuscite a oltrepassare la pagina 40. Le due protagoniste, la portinaia e la bambina, sono così antipatiche all’inizio, con la loro supponenza e presunzione (descritte bene, per carità! con uno stile vincente nel renderle credibili e vere) irritano e mi hanno subito indisposto. Ho trovato solo un pochino commovente il racconto che la portinaia fa della morte del marito. Ma una sensazione tiepida… poi, ho iniziato a saltare pagine su pagine e quando, si sa, di un libro si saltano le pagine significa che qualcosa nel libro non va… Sorry, non a tutti piacciono le stesse cose…
-

Per fortuna che vale il solito de gustibus. Ero curioso di capire le motivazioni, perché a me sinceramente non venivano in mente. Io per esempio ho provato subito una forte simpatica verso entrambe, e la supponenza e la presunzione che hanno trasmesso a te, a me non l’hanno trasmessa. Per me loro due sono semplicemente diverse, animali in un habitat sbagliato. E’ sorprendente che lo stesso romanzo possa lasciare impressioni così diverse e mi rassicura sempre l’esistenza di un confronto letterario. Un abbraccio.
-
Mi sono appena ricordato di avere odiato le prime pagine di questo libro. Mi sembrava una ciritca verso lo snobismo dell’alta società, scritta però in modo ancora più snob e indisponente. Poi ovviamente ho cambiato idea e l’ho amato, ma la prima impressione non fu affatto positiva
-
-
-
-
-
Eccomi, amico
beh sì, gnente mi emoziona se gnente fa vibrare i campanellini interiori. La scelta di un libro richiede più di un sentito dire. Direi che richiede un “sentire” personale, intimo. Un tempo l’ho fatto: mi fidavo delle recensioni, dei pareri, delle copie vendute, delle ristampe. Una sola volta ho “beccato” bene nei suggerimenti. Con David Grossman in Che tu sia per me il coltello. Che meraviglia di Autore! Non dirlo a nessuno shhhhhh… io i libri li annuso come annuso chi li suggerisce. E qui c’è un buon profumo. Grazie.-

Mi sono appena fatto la doccia con Felce Azzurra Elegance, un bagnoschiuma sublime.
-
-
navemossa, che libro che hai citato… che emozioni, che coltellate.
che gnente gnente potemo amicarci, xe’ mi piacerebbe un moccio.
gran bel libro anche l’eleganza, e di kakuro ozu ne vogliamo parlare?
poi ho visto il film che fa registrare uno degli spread più alti libro/film della storia in quanto certe sensazioni pensate il film non le può rendere. E non le rende.-

Grazie del consiglio ragazzi, lo leggerò! E’ fantastico avere la possibilità di confrontarci sugli autori, sceglierli anche per l’entusiasmo che ci trasmettiamo.
-
-
-
-
Ciao,
sono Matteo

Sono nato a L’Aquila nel 1981.
Adesso vivo a Firenze, insegno ai bambini della scuola primaria e scrivo romanzi definiti “per bambini e ragazzi”, ma io dico non vietati agli adulti…
Restiamo in contatto?
Notizie recenti…
…e tanti altri!







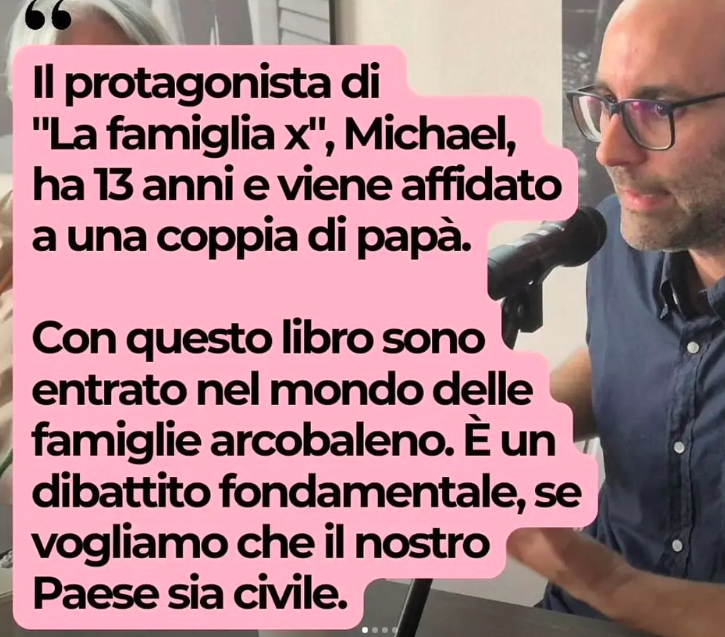


Lascia un commento