Le fotografie delle famigliole sorridenti, davanti alla nave semi-affondata, tristemente celebre di Costa, hanno riaperto una ferita. Un gran vociare su una strada non più abituata. Pantaloncini, t-shirt dai colori accesi della piena estate, zainetti in spalla, cappellino, una mano nella mano del proprio bambino e la digitale, pronta a scattare, nell’altra. Li guardo tutti, tanti provenienti da ogni parte d’Italia, pochi pure da qualche città degli Stati vicini, passeggiare a pochi metri da me, che mi sento un alieno nella mia città, che non posso riconoscere in quella condizione alla quale ancora non mi abituo, ora che sono passati quasi 3 anni, figuriamoci a poco più di un anno dalla fine del mondo. Ognuno ha un mondo suo, e non occorre che finiscano tutti in sincronia per poter dire che è finito il mondo. Il mio è finito il 6 aprile del 2009. Ne ho ricostruito un altro fatto di pezzi che non si incastrano, un mondo riciclato, fai da te, senza istruzioni, con materiali poveri tenuti assieme da un incalcolabile amore per la vita, pure nell’assenza.
La vita genera vita in una moltiplicazione che ha inizio in un punto, il principio nel quale sta il seme, in attesa di acqua che lo nutra e faccia spuntare microscopiche radici che attecchiscano alla terra e trovino, in uno stelo sottilissimo, la forza di attraversarla. Io ho visto la vita rinascere dal niente, dove non c’erano semi, come un miracolo che non voglio condividere, che non voglio raccontare, del quale non m’importa parlare, il mio miracolo, intimo, nel buio di una solitudine sconosciuta, infastidita a morte da tutto quel chiacchiericcio a L’Aquila, in Via XX Settembre, a Ferragosto del 2010.
Chiudo gli occhi ed entro in uno di quei palazzi. Mi permetto di farlo solo col pensiero, pur sapendo di non esserne degno. Facilissimo farlo solo col pensiero, quando qualcuno, molti, avrebbero voluto trovarsi a mille miglia da lì, o anche appena fuori, e invece erano dentro, non per loro volontà, a vivere gli ultimi istanti, quando avevano 100 anni ancora davanti, dio mio. Dall’interno, lo spettacolo sovrumano di tanti esseri (sovr)umani in gita fuori porta a L’Aquila, il giorno di Ferragosto, ha fattezze peggiori, perché più dolorose, come frecce che congiungono i sorrisi, all’ingiustizia di bocche abbandonate su pietre; le mani intrecciate, all’ingiustizia di mani ferme su pietre; le passeggiate di Converse, all’ingiustizia di gambe e piedi immobilizzati dalle pietre; tanta felicità, all’ingiustizia di una incommensurabile infelicità eterna, di chi non avrà più motivo di vivere, ora che manca chi il motivo lo accudiva, eppure deve vivere per forza; il bisogno di fermare con un click le proprie facce sorridenti davanti all’abisso, al buio, al silenzio lasciato dal boato, preceduto dalla gioia giovane di chi L’Aquila la sceglieva e poi imparava a voler bene a ‘sta città, nonostante tutto.
Torno in me, ad abitare il mio corpo immobile in un punto qualunque della strada, chiedo ancora scusa per aver calpestato, seppur solo con la mente, i pavimenti delle vostre stanze vuote, anzi, piene zeppe di dolore, perché tutto si avverte tranne il vuoto, in questo pieno che fa male. Da qui, fermo sul marciapiede, mi domando cosa ci fanno tutti su Via XX Settembre.
Non si rendono conto di essere l’unica forma di vita in questa strada? E allora perché permettono ai loro bambini di schiamazzare, perché implorano l’un l’altro di fotografarsi, perché si incitano e si consigliano pose carine, pose ammiccanti, pose da luna park?
Le fotografie dei turisti del macabro, con sullo sfondo mezza nave, hanno riportato in alto l’interrogativo. Non ho ancora trovato una risposta alla voluttà di comparire davanti alle macerie di una storia dal pessimo finale.
Senza condanna, per carità, con un misto di pena e vergogna, certamente, e nessuna, nessuna spiegazione.
Ferragosto 2010, Via XX Settembre, L’Aquila
Pubblicato il
19 risposte a “Ferragosto 2010, Via XX Settembre, L’Aquila”
-
Una sola parola: Vergogna! Come ho già scritto sul mio blog…è tutta colpa dei media!!!
-

E delle persone medie, anzi mediocri.
-
-
Senza condanna? Non lo so. Anch’io tendo a non condannare, ma in questi casi boh, mi riservo la facoltà di farlo, eventualmente 🙂
Guarda, meglio riderci su. http://friendfeed.com/isolavirtuale/fc9518f4/foto-ricordo -
Dicembre 2001, cena a casa mia con amici vari, uno di loro è da poco tornato da NY. Ad un certo punto monta il proiettore per le diapositive ed inizia a proiettare foto di lui ed un’amica scattate nel luogo dell’attentato. Un downtown stravolto, macerie ovunque, robe che una volta stavano in piedi da sole che ora si presentano puntellate con ferri, paletti e via dicendo. Lui e la sua amica in primo piano con un sorriso a 32 denti. Dimmi tu. Alla terza diapositiva gli ho chiesto se poteva smettere di farcele vedere. Da allora il tizio non mi guarda ancora in faccia, perchè per lui sono stato maleducato (notare che si trovava a casa mia).
Ora…. c’è un gusto tutto umano nel volere entrare nei luoghi di disgrazie. Forse è un modo per esorcizzare gli eventi negativi, ma di certo io mi sento alieno a questo modus. Un abbraccio e il massimo rispetto a te e tutti gli Aquilani.-

Niko, hai fatto benissimo a fare la richiesta che hai fatto. Io mi sarei comportato allo stesso modo. Se il tuo amico non ti guarda più in faccia, dimostra ulteriormente quel che aveva già ampiamente dimostrato con le sue diapositive.
Claudia, diciamo un condannare senza impegno. ;P L’immagine è carinissima. La notorietà che quei 2 stanno ottenendo è la loro giusta punizione. Spero non ne vadano fieri, ma forse, a ‘sto punto, per quello che dimostrano di essere e ricercare, sicuramente sì.
-
-
Matteo ma poverini…ma non ti fanno pena? Ma ti rendi conto di cosa hanno bisogno per dare un senso a quella loro particolare giornata? Ti rendi conto in che bassezza sono obbligati a sprofondare per far credere di essere felici? Che sono forzati in quelle viscide rimostranze di denti davanti a un obbiettivo e di fronte a quella che per altri è la perdita della vita. E fanno anche dei chilometri! Non arrabbiarti Matteo, l’unico sentimento che devono scaturirti è quello della pena. E’ davvero quello che penso. E a quanto siamo ricchi e forti noi. Un abbraccio forte.
-
Be’… sai com’è…
Anche questa è l’italica realtà (triste)
Io preferisco festeggiare la vita, non la morte…
Mentre, in una sorta di macabra realtà, ci sono pellegrinaggi per vedere il triste epilogo di qualsiasi avvenimento proclamato dai mass media.Ti abbraccio fortissimo
-
Sono persone che hanno perduto la sensibilità verso il dolore altrui, che non sono nemmeno capaci di vergognarsi, non conoscono pudore e anzi pensano di vivere in un enorme grande fratello, perché la loro vita è mediata dall’immagine, la loro percezione del mondo è legata a ciò che si vede, alla necessità di esserci, sempre e di avere una foto da postare da qualche parte sul web.
Pensa Matteo, quando io sono stata a visitare un campo di concentramento, del quale non ho scattato nemmeno una foto, ho visto persone mettersi in posa e sorridere davanti al forno crematorio.
Non so che dire, mi stupisco sempre e sempre mi ripeto che bisognerebbe in qualche maniera far comprendere il senso della vita, del dolore e di certe mancanze a chi, evidentemente, pare non capire.
Un abbraccio, oggi un po’ più forte! -
Col pensiero mi permetto di abbracciare le tue parole. Una ad una. Sole. Impotenti. L’inspiegabile. Invece è spiegabile. E la spiegazione non lascia speranza, ad un anno dalla fine del mondo. A 3 dalla fine del nostro mondo.
Siamo diventati eccessivamente finti. Così me lo spiego. Finti a tal punto che anche la realtà della morte non merita più rispetto. Eppure basterebbe il racconto di qualcuno, di qualcuno che c’era, che l’ha vissuto. Un racconto, finto per definizione, che sappia riportare la realtà tra i finti. Dico che non c’è speranza, eppure forse c’è ancora.Un abbraccio, Matto.
-
Come la gente che si faceva le foto davanti al portone del garage di Michele Misseri…che schifo…
-
anni fa quando era stato ucciso Versace ho visto turisti farsi fotografare davanti alla sua villa di Miami, alcuni perfino riversi per terra nella posizione del ritrovamento del suo corpo, se avessero avuto del ketchup se lo sarebbero messo per simulare il sangue.
La cosa mi aveva scioccata e inorridita. Nessun rispetto per la persona uccisa. Tutto fa sensazione, tutto è fonte di turismo. Anche la città dove era stata uccisa la studentessa americana.
La gente pensa che il mondo là fuori sia finzione, film. Anche il modo in cui vengono date le notizie in TV… per fare sensazionalismo, audience.
Anni fa mi era capitato di essere sul luogo di un incidente d’auto dove un furgone era stato travolto, e dentro, incastrato nelle lamiere, c’era un passeggero. La scena era terribile e vedere quell’uomo sofferente e intrappolato. Hanno chiamato ambulanza, vigili, e sicuramente lo avranno liberato. Ma la cosa scioccante è stato vedere una bambina passare di lì in bici con la madre. La bambina di circa 8 anni, era entusiasta delle scena e non voleva andare via, la madre non l’ha sgridata, non le ha fatto cogliere la tragedia del momento, che non è un film ne un gioco. Tra le due reazioni era peggiore quella della madre.
Quindi non mi sciocca nulla… anzi. Strano che non ci siano stati voli charter per Fukushima…-

Jasmine, strano eh? Chissà perché proprio là a Fukushima il turismo dell’orrore è mancato!
Roberto, o come chi gli chiede l’autografo.
Chiappanuvoli, forse hai ragione. Il confine fra vita e fiction si fa sempre meno marcato, anche grazie ai mezzi di comunicazione che fanno, della tragedia, la fiction più seguita e si fanno i complimenti da soli per gli ascolti.
Miss Fletcher, è difficile far conprendere a chi non ha dentro la quantità minima di sensibilità necessaria.
Grazie Devis!
Topina, per questo non riesco ad arrabbiarmi.
-
-
Non lo capisco neanch’ io.
-
I turisti che raggiungono certi luoghi per il semplice gusto dell’orrido e del “tutti ne parlano” mi fanno davvero ribrezzo e mi fanno anche arrabbiare alquanto.
-
Sicuramente è gente che non ha il minimo concetto di vacanza né tantomeno di turismo culturale..
-
Perché il rispetto è talvolta concetto sconosciuto a chi non ha mai dovuto pretenderlo.
-
Io mi vergogno tanto di questo turismo-sciacallaggio basato sulle tragedie. E mi vergogno di come certe persone facciano le foto sorridenti con lo sfondo di una tragedia.
Come già detto in un commento su un tuo post precedente, io non so come ci si possa sentire a vedere queste cose. Non mi fa rabbia, ma tanta, tanta, tanta tristezza.Mi dispiace.
-

MisterGrr, non lo sanno neppure loro, i turisti, come ci si sente. Per questo non riesco ad augurare loro cose brutte.
Jaku, potrebbe provare a immaginarlo, però. Provare.
Gogan, né di vergogna, forse. Chissà di cosa si vergognano loro, nella vita.
Giovy, qualcuno dovrebbe dirglielo direttamente.
Mammamsterdam, sarebbe interessante che qualcuno di coloro che l’hanno fatto e lo faranno spiegasse, a noi che non lo capiamo, il gusto che prova.
-
-
Grazie
Ciao,
sono Matteo

Sono nato a L’Aquila nel 1981.
Adesso vivo a Firenze, insegno ai bambini della scuola primaria e scrivo romanzi definiti “per bambini e ragazzi”, ma io dico non vietati agli adulti…
Restiamo in contatto?
Notizie recenti…
…e tanti altri!



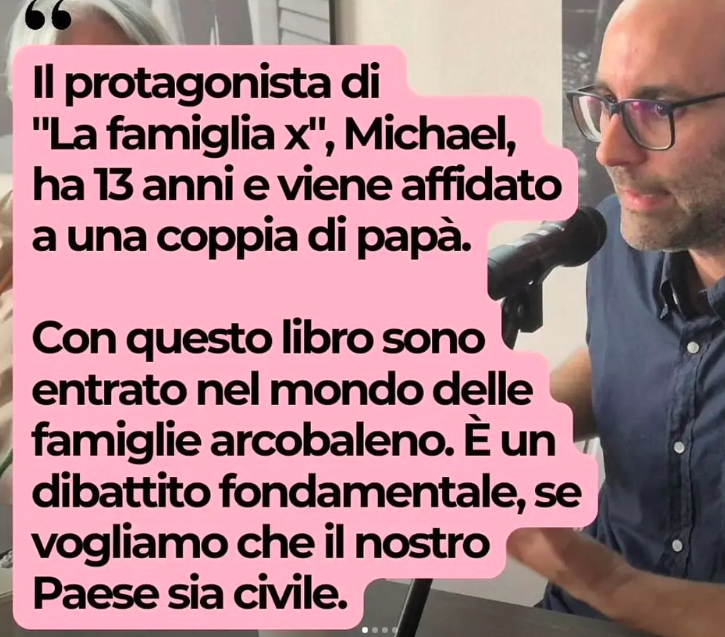



Lascia un commento